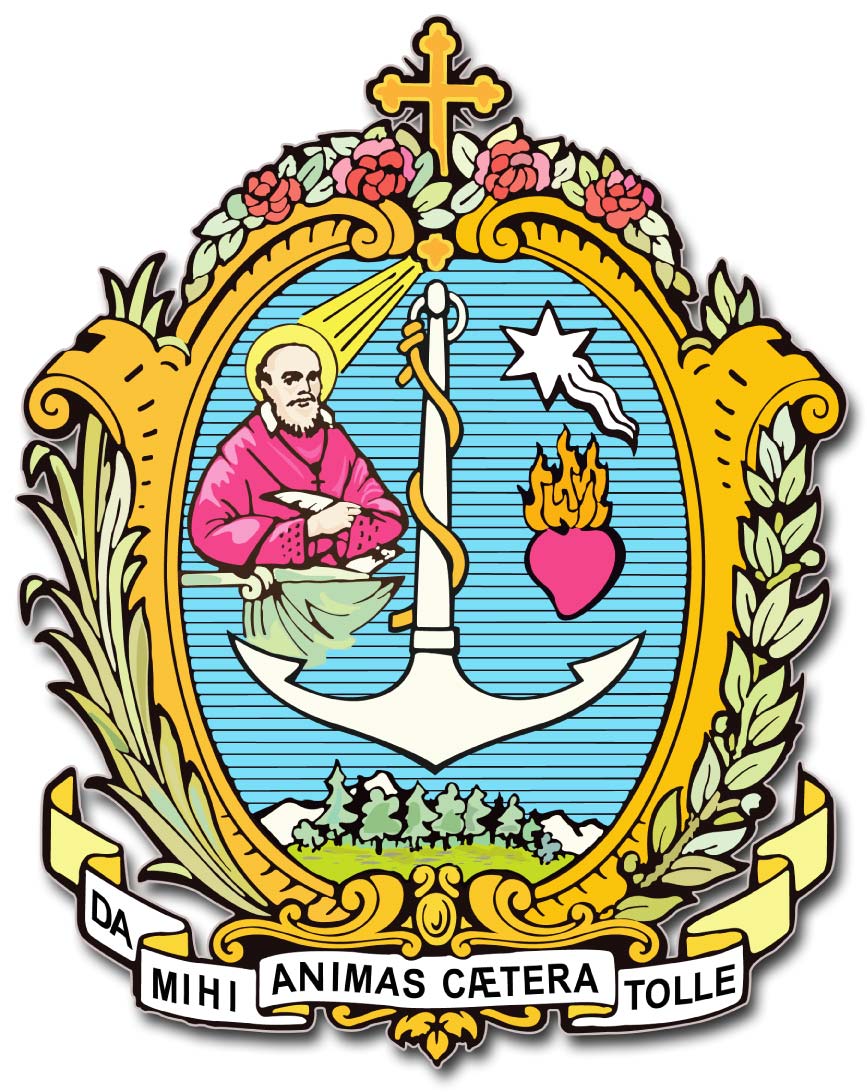I Salesiani a San Benigno
Dalle origini ad Oggi
L’Istituto Scuole Professionali Salesiane, fondato da don Bosco a San Benigno Canavese nel 1879, utilizza i locali dell’antica Abbazia di Fruttuaria, ristrutturati dal cardinale Delle Lanze. La Casa fu inaugurata nell’estate del 1879. All’inizio fu sede per i novizi, ma già nell’autunno sorsero anche i laboratori, umili e rudimentali: sarti, falegnami, fabbri e legatori. Era l’inizio dell’attività caratteristica di San Benigno. Ci furono varie trasformazioni, ma la Casa si mantenne sempre nella linea del lavoro. Per vari decenni ci furono i tipografi ed anche una scuola agricola al “Molino”. Sempre al Molino funzionò una rudimentale centrale elettrica che assicurò l’illuminazione a tutto il paese. Nel 1904 aprirono le scuole serali e l’Oratorio festivo.
In tempi più vicini fu fiorente l’avviamento professionale, che in seguito si trasformò in Scuola Media e Centro di Formazione Professionale, che attualmente accolgono circa 900 allievi quotidianamente.
Comunità
Chi sono i salesiani
La Società Salesiana di San Giovanni Bosco (in latino Societas Sancti Francisci Salesii) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio; membri di questa congregazione clericale, detti comunemente salesiani, pospongono al loro nome la sigla S.D.B..
La congregazione fu fondata nel 1859 da san Giovanni Bosco nel rione Valdocco a coronamento della sua lunga e intensa esperienza di apostolato tra la gioventù povera di Torino; i salesiani ricevettero il pontificio decreto di lode nel 1864 e le loro costituzioni furono approvate dalla Santa Sede nel 1874. I salesiani si dedicano specialmente all’istruzione e all’educazione della gioventù in scuole, oratori, centri di formazione agricola e professionale, ma anche all’apostolato della stampa e alle missioni.
Dall’A.S. 2020-21 sono membri della Comunità salesiana di San Benigno anche i confratelli residenti al Cagliero di Ivrea.
I membri della nostra
Comunità

Don Pier Majnetti
Direttore della casa

Sig. Lucio Reghellin
Direttore del CFP

Don Alessandro Botalla Buscaglia
Incaricato dell’oratorio

Don Ervino Bruna

Don Francesco Mosetto

Sig. Ilario Carboni

Sig. Francesco Naldi

Sig. Franco Ceppa

Don Silvio Gignone

Don Dante Pietrobon
La congregazione Salesiana
Da Mihi Animas Caetera Tolle
San Giovanni Bosco conosceva bene il valore della collaborazione con tutte le forze positive della società per rendere possibile un progetto di sviluppo integrale dei giovani. Con l’incremento graduale e continuo del numero di assistiti, si rese conto dell’impossibilità di provvedere personalmente a tutto, essendo le sfide sempre nuove e più complesse. Cominciò quindi a circondarsi di collaboratori che condividessero con lui il desiderio di un futuro migliore per i ragazzi. Alcune esperienze di delusione per l’abbandono nel momento del bisogno lo convinsero però a cercare una base più stabile per la propria opera, fondando una Società (di San Francesco di Sales) che di fronte allo Stato fosse pienamente in regola, ma i cui membri fossero legati da impegni di vita fondati sulla religione. Tra i suoi ragazzi più grandi trovò adesione entusiasta e così nacque la Congregazione Salesiana. Oggi si sviluppa in 132 nazioni del mondo e conta circa 15000 membri.
Al vertice, successore di Don Bosco, si trova il Rettor Maggiore, attualmente don Angel Fernandez Artime. I Salesiani di Don Bosco (SDB) possono davvero riconoscere nelle Costituzioni della Congregazione:
“Con senso di umile gratitudine crediamo che la Società di san Francesco di Sales è nata non da solo progetto umano, ma per iniziativa di Dio. Per contribuire alla salvezza della gioventù, “questa porzione la più delicata e la più preziosa dell’umana società”, lo Spirito Santo suscitò, con l’intervento materno di Maria, san Giovanni Bosco.
Formò in lui un cuore di padre e di maestro, capace di una dedizione totale: “Ho promesso a Dio che fin l’ultimo mio respiro sarebbe stato per i miei poveri giovani”. Per prolungare nel tempo la sua missione lo guidò nel dar vita a varie forze apostoliche, prima fra tutte la nostra Società”